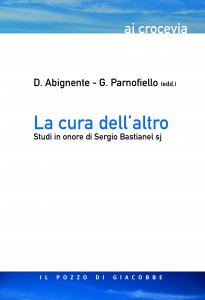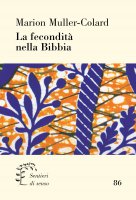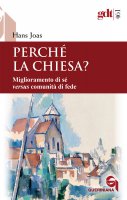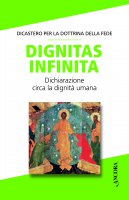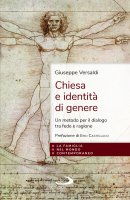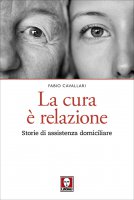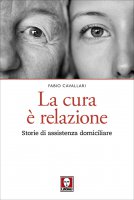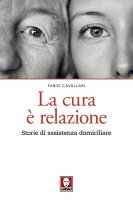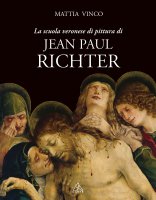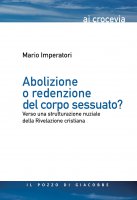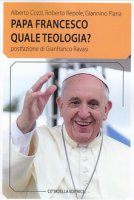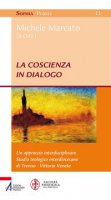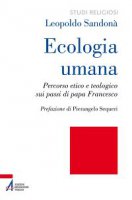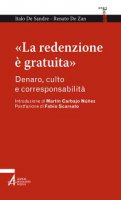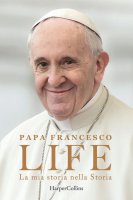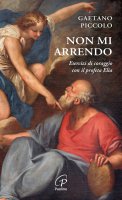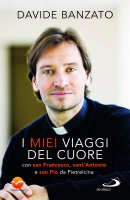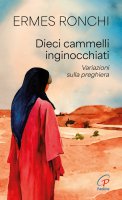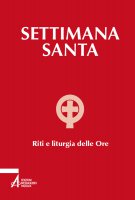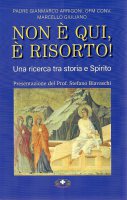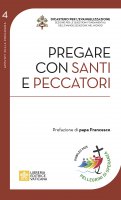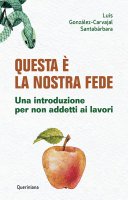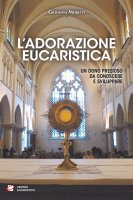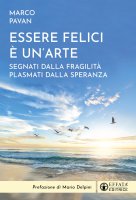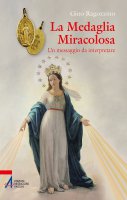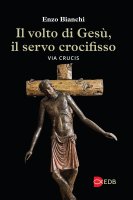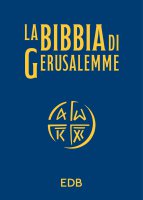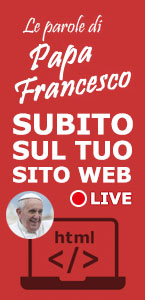La cura dell'altro
-Un volto umano e spirituale della teologia morale
(Ai crocevia)EAN 9788861245532
| Disponibile anche come | Prezzo |
|---|---|
| Libro usato | da 16,25 € |
| 1 pezzo in stato usato come nuovo | 25,00 € → 16,25 € |
| 1 pezzo in stato usato come nuovo | 25,00 € → 16,25 € |
-
-
-
-
-
27,00 €→ 25,65 € -
-
-
-
-
-
20,00 €→ 14,00 € -
-
-
-
-
-