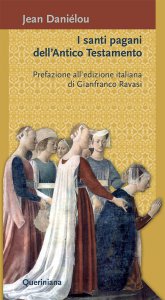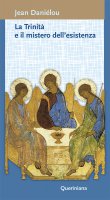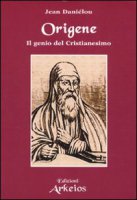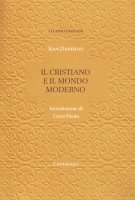I santi pagani dell'Antico Testamento
(Meditazioni)EAN 9788839914774
Pubblicato la prima volta in francese nel 1956, questo volume intenso aiuta il lettore ad allargare gli orizzonti della fede cristiana. Jean Daniélou, teologo e storico del cristianesimo, rilegge i testi dell’Antico Testamento secondo una riflessione teologica non usuale ai suoi tempi sui personaggi biblici che non rientrano nelle tradizionali categorie di appartenenza al popolo e alla fede d’Israele, né tantomeno alla comunità cristiana. Sono coloro che non hanno conosciuto la rivelazione del Dio di Abramo: quanti cioè hanno vissuto in un regime che l’autore preferisce chiamare di “religione cosmica” che, pur precedente temporalmente Abramo, non manca di mostrare verità teologiche proprie. In questo Daniélou anticipa profeticamente le affermazioni del Vaticano II sui semina Verbi (cfr. AG 11; NA 2). Ma soprattutto riprende una salda tradizione patristica, che si esplicita per esempio in Gregorio Magno. Inizialmente nate come conferenze pubbliche, le riflessioni raccolte ordinatamente nel libro costituiscono lo spunto per una seria «teologia missionaria che cerca di ravvisare l’unità del disegno di Dio nel susseguirsi delle alleanze» (p. 24). Senza mettere dunque in dubbio l’unicità della salvezza in Cristo, i personaggi dell’Antico Testamento messi qui a fuoco dimostrano l’ampiezza dell’amore del Padre, che vuole salvare ogni uomo (cfr. 1 Tm 2,4). Nascono così le pagine dedicate ad Abele, Enoc, Daniele, Noè, Giobbe, Melchisedek, Lot, la regina di Saba. Ne scaturisce quella che Ravasi nella prefazione definisce «un’ideale galleria di ritratti spirituali, ognuno espressione di una particolare via alla santità» (p. 9). Un volume prezioso ancora oggi, che non ha affatto perso la sua attualità e suggestione, sia dal punto di vista teologico che spirituale, catechetico e liturgico.
Tratto dalla rivista "Parole di Vita" n.3 del 2018
(https://www.queriniana.it/parole-di-vita)
-
-
-
30,00 €→ 28,50 € -
-
-
-